Dal volume “Seducenti immagini”di Camille Paglia (Società Editrice Il Mulino, Bologna 2012, pp. 294), pubblichiamo il capitolo Stelle cadenti. Jackson Pollock, Argento Verde.

Blue Poles – Jackson Pollock – 1952.
L’Espressionismo astratto ha conquistato il design moderno, dove è diventato un motivo decorativo consueto per qualsiasi cosa, dalla carta regalo al linoleum da cucine.
Sorprende tuttavia che negli Stati Uniti molte persone fuori dei centri urbani guardino ancora alla pittura astratta con sospetto, come se fosse uno scherzo o una truffa. Preso atto di questa tenace scetticismo, faremmo forse bene a riconoscere che l’arte astratta è più spesso scadente che buona, e che nel corso dei decenni una quantità di goffe imitazioni ne ha compromesso il valore. Ragione di più per celebrare i capolavori di questo difficile genere.
Jackson Pollock fu al tempo stesso beneficiario e vittima del culto americano della celebrità. Fu la prima superstar dell’arte americana, che era rimasta da sempre all’ombra di quella europea. All’indomani della Seconda Guerra Mondiale, divenne un simbolo del trasferimento della capitale mondiale dell’arte da Parigi a New York, dopo secoli di predominio francese. Nato in un allevamento di pecore nel Wyoming, Pollock sembra incarnare la rude indipendenza della frontiera americana. L’abbigliamento rozzo e le sue maniere brusche valsero a infrangere l’immagine stereotipata degli artisti, che gli americani, inclini al senso pratico e al conformismo, con sprezzo giudicavano spesso smidollati o snob.

Jackson Pollock e Lee Krasner.
Se la sua famiglia aveva radici nel pionierismo – la madre era nata in una capanna di legno nell’Iowa –, il giovane Pollock era tutt’altro che un campione di virilità. I vicini lo descrivevano come un cocco di mamma e un piagnucolone. Timido e impacciato, rifuggiva dagli sport e giocava con le ragazze. Nella tarda adolescenza prese a studiare teosofia e ad ammirare Krishnamurti, il guru dandy di cui scimmiottava i capelli lunghi e i colletti aperti alla Byron. Paradossalmente, fu solo dopo essersi trasferito a Manhattan che, conquistato dal fascino del suo maestro, il virile pittore di murali Thomas Hart Benton, Pollock si trasformò nell’iconico artista cowboy destinato ad esplodere nel mondo intero. Già allora soffriva di alcolismo cronico, che lo condusse al ricovero psichiatrico negli anni Trenta. Una patologia che lo afflisse per tutta la vita e che gli causò a più riprese danni e infortuni, culminati nel 1956 in un incidente d’auto nelle vicinanze della sua fattoria di Long Island, in cui rimase ucciso insieme alla donna che gli sedeva accanto.
In origine Pollock voleva fare lo scultore e sognava di eguagliare Michelangelo. Quand’era studente all’Arts Students League di New York cominciò a dipingere quadri naturalistici, ma si sentiva insoddisfatto e frustrato per le difficoltà che incontrava nel disegno. Le grandi mani gli tremavano, senza contare che da piccolo era rimasto mutilato dell’indice destro in un incidente con una scure. Praticò il Realismo sociale di Benton, poi si diede al primitivismo teatrale del muralista messicano José Orozco. La vera rivoluzione per lui fu tuttavia Picasso. Pollock non nutrì alcun interesse per il Cubismo fino a quando vide Les Demoiselles d’Avignon e Guernica a una retrospettiva organizzata nel 1939-1940 dal Museum of Modern Art. Rimase galvanizzato dalle grandi e aggressive forme picassiane, dalla mancanza di profondità dello spazio cubista e dalla visione ambivalente della donna mitica: elementi che combinarono con la psicoterapia archetipica di matrice junghiana da lui intrapresa.
Dallo zelo emulativo nei confronti di Picasso scaturirono le prime opere con cui conquistò l’attenzione del pubblico: dipinti inquietanti di oscure figure totemiche, realizzate in uno spirito criptico e semiastratto. La fama di Pollock come uomo violento cominciò presto. Era stato sempre un forte bevitore compulsivo (i conoscenti dicevano che aveva una personalità «Jekill e Hyde»), ma a quel punto i suoi dipinti virarono verso il grottesco. Un quadro del 1938-1940, senza titolo ma chiamato poi Un uomo nudo con coltello, mostra un aggressore ipermuscoloso che potrebbe essere un sacrificio rituale. La composizione è bloccata e parossistica, una massa aggrovigliata di carni color marrone-sangue che si dimenano. Questo straordinario tumulto emozionale era l’«espressionismo» nel nuovo stile di Pollock: un’emersione dell’angoscia prodotta dalla sua tormentata vita interiore. L’artista moderno, secondo Pollock, lavora «dal di dentro», «esprimendo, piuttosto che illustrando, i propri sentimenti».

Mural – Jackson Pollock – 1943.
Anche quando il suo stile si fece sempre più astratto, Pollock continuò a cominciare ogni quadro con una figura, che finiva poi per nascondere. «Voglio occultare che può essere raffigurato», affermò. Tracce di queste figure via via diminuirono e alla fine scomparvero del tutto: una transizione che si può vedere in Mural, un dipinto gigantesco (lungo più di sei metri e alto circa due e mezzo) che egli realizzò nel 1943 per l’ingresso della casa newyorchese dell’ereditiera Peggy Guggenheim, collezionista e mercante d’arte. Vi si può individuare una processione di omini neri stilizzati che marciano fra tratti ondulati, che i critici ostili definirono «un’apoteosi di carte da parati» e un «pasticcio di maccheroni». Mural, che Pollock asseriva di aver dipinto in una sola notte, era eseguito nel suo epocale stile all-over, «a tutto campo»: la superficie è trattata in modo uniforme, da un bordo all’altro, non c’è parte del dipinto che sia più importante di un’altra.
Per quanto fosse già diventato l’enfant terrible del mondo dell’avanguardia newyorchese, Pollock e la schietta moglie, l’artista Lee Krasner, pativano la povertà e gli stenti perché i loro quadri non si vendevano. La sua produttività però non conobbe mai flessioni. Durante l’estate del 1947 ci fu una svolta decisiva: inventò il suo caratteristico dripping, lo stile destinato a trasformare l’arte contemporanea. Dopo aver srotolato fogli di tela olona grezza sul pavimento del suo piccolo studio-granaio, usava stecche e pennelli induriti per scagliare e cospargere vernice sulla tela. Prima di allora, aveva spremuto normali colori a olio direttamente dal tubetto su tutta la superficie dei quadri, per poi stenderli con una spatola. Prese a usare

Un articolo sull’arte di Jackson Pollock.
materiali commerciali poco costosi – vernici da casa, smalti industriali, vernice argento per radiatori – e smise del tutto di toccare la tela, tranne che per camminarvi sopra. Questo trattamento libero del colore aveva avuto dei precedenti negli esperimenti a cui Pollock aveva assistito da studente, nel laboratorio fondato a New York dal muralista messicano David Alfaro Siqueiros, che li chiamava «causalità controllate».
Ingrandendo significativamente le dimensioni delle tele e lavorando sul pavimento, Pollock riscattò la pittura da cavalletto, che a partire dal Rinascimento era stato fondamentale per i dipinti trasportabili. Camminando intorno alla tela e improvvisando da tutti e quattro i lati, Pollock diceva di poter entrare «letteralmente nel dipinto», un’esperienza che paragonava al «metodo della pittura su sabbia degli indiani d’Amrica». L’amico scultore Tony Smith ne sottolineò la predilezione «per il suolo» e diceva che il pavimento era «la terra» che l’artista «disseminava di fiori». A un altro amico artista Pollock ebbe a dire: «Io sono natura». Definiva il dipinto «l’arena», come quella delle corride: era diventato un luogo in cui non esisteva più sopra o sotto.
Non prendeva mai decisioni definitive sul verso o sulla posizione dei quadri, se non dopo averli studiati per settimane. Imbullettare le tele alla parete così come era destinate ad essere esposte al pubblico era un passo molto inoltrato nel processo creativo. Firmava malvolentieri i quadri e non gli piaceva inventare titoli, che alla fine divennero semplici numeri.
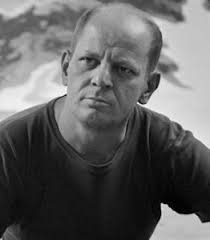
Jackson Pollock
Un sensazionale profilo pubblicato dalla rivista «Life» nel 1949 rese Pollock improvvisamente famoso. In tono di scherno il titolo dell’articolo domandava «È lui il più grande artista vivente negli Stati Uniti?». La foto lo ritraeva vestito in panni di lavoro e con la sigaretta che gli pendeva dalle labbra, in una posa combattiva con le braccia conserte, appoggiato contro un dipinto pieno di ghirigori che alla maggior parte dei lettori sembrò assurdamente caotico. L’articolo contribuì a creare quello stereotipo del pittore astratto come tipo strambo e sudicio destinato a diventare un sordido ingrediente del cinema e della Tv americana degli anni Cinquanta.
Un saggio polemico sugli astrattisti newyorchesi apparso in una rivista d’arte coniò l’espressione action painting, «pittura d’azione», con cui si intendeva dire semplicemente che il nuovo scopo della creazione artistica era l’atto del dipingere in sé, e non il prodotto finale. Pollock, per esempio, non faceva mai schizzi preparatori, ma disegnava con la vernice direttamente su tela. Ciò nonostante fu perseguitato dalla caricatura dell’action painter che lancia pittura in giro per la stanza in preda al delirio.
Una fotografia a tutta pagina sull’«Harper’s Bazar» di un Pollock meditabondo, in giacca di cotone e jeans, accovacciato sul predellino della sua vecchia automobile, valse a fonderne l’immagine con quella di Marlon Brando, che aveva introdotto un brutale naturalismo nella recitazione teatrale e cinematografica. Il parallelismo con Brando si fece palese in un articolo del 1956 pubblicato su «Time» e intitolato I selvaggi (The Wild Ones, che citava il biker movie di Brando), in cui Pollock veniva soprannominato «Jack il Gocciolatore» (Jack the Dripper), quasi fosse un maniaco omicida. Il suo atteggiamento anticonformista veniva anche accostato alla poesia beat ribelle, all’esistenzialismo e alla nascita del cool nella musica jazz (che a casa ascoltava di continuo).

Jackson Pollock e Peggy Guggenheim.
L’attenzione dei media esercita un’enorme pressione su Pollock, che si trovò di fronte ad aspettative impossibili. Malgrado la celebrità, le vendite dei suoi dipinti, che avevano avuto una breve impennata, rimasero fiacche, tanto che Peggy Guggenheim ebbe difficoltà anche a donarli: la Yale University rifiutò l’offerta di Murale, che fu infine accettato dal Museum of Art della University of Iowa, dove si trova tuttora. Ci furono tensioni anche con altri pittori newyorchesi, risentiti per come i media avevano eletto Pollock a loro capofila. I rapporti con i colleghi artisti furono sempre scabrosi e a volte ostili: una volta tentò di distruggere una scultura di Larry Rivers investendola con l’auto in una strada privata a East Hampton. Durante il triennio dei suoi classici drip painting, Pollock si mantenne sobrio. Nel 1950, dopo essere stato filmato mentre lavorava all’aperto su una lastra di vetro, riprese a bere. La giornata si risolse in una catastrofe farsesca: rovesciò il tavolo della sala da pranzo, scaraventando a terra i piatti con il roast-beef dei dodici commensali. Nella febbrile trasformazione del suo stile, Pollock cominciò a usare delle siringhe per arrosti per versare vernice nera su tele bianche grezze: era la tecnica nota come soak-stain («imbibizione a macchia»), che fu poi perfezionata da Helen Frankenthaler. Ma la sua produzione, un tempo prodigiosa, calò miseramente, mentre si moltiplicavano gli episodi di ubriachezza, spesso nella chiassosa Cedar Tavern, dove malmenò delle donne e scardinò la porta del bagno. Fratturatosi una caviglia, prese a ingrassare, e venne così assumendo un aspetto gonfio, devastato e prostrato. Nel mondo dell’arte furono in pochi a stupirsi quando morì tragicamente, a soli quarantaquattro anni.

Jackson Pollock mentre dipinge.
L’uomo Pollock finì forse per sprofondare nello squallore e nella disgrazia, ma l’artista lasciò dietro di sé una mole immensa di opere originali e straordinarie, che vanno da terrificanti apparizioni di sofferenza ad abbaglianti composizioni di bellezza sublime.
Nessuno è stato in grado di imitare le sue matasse intricate di colori che si librano nei più grandi drip painting, una ragnatela di splendide scie dove non c’è mai confusione né disordine. Le sue linee vorticose sono sospese in zona strana, non identificabile, tra lo sfondo privo di profondità e la ruvida superficie, che è densamente stratificata di pigmento e dove a volte s’incastonano oggetti reali – chiavi, chiodi, mozziconi di sigaretta, tappi di bottiglia –. In virtù di questa incrostazione progressiva (ogni mano di pittura doveva asciugare prima di applicare la successiva), le tessiture cromatiche di Pollock hanno la concretezza ombreggiata della scultura, genere al quale aveva rivolto in principio le sue aspirazioni.
È impossibile apprezzare i colossali quadri di Pollock dalle riproduzioni, che li rimpiccioliscono alla triste dimensione di una pagina. A vederli di persona, sopraffanno lo spettatore con la loro maestà. Soltanto i primi piani dei dettagli possono comunicare la complessità soggiogante di quelle superfici increspate, intricate, disseminate di sappia e luccicanti di colori metallici e pezzi di vetro.

Argento Verde – Jackson Pollock – 1949.
Un piccolo dipinto senza titolo ma noto come Argento verde, eseguito in smalto e pittura d’alluminio su carta montata su tela, coglie l’inebriante energia del più raffinato dripping di Pollock. Anelli, volute, chiazze luminose posseggono un’incantevole festosità. Su uno sfondo acquamarina schizzano zampilli calligrafici di colore smorzato e filiformi linee nere, che producono un fermento in ebollizione. Che cos’è, oceano, aria, cielo? Il dipinto è insieme un sistema meteorologico, un universo mentale, una mappa neurologica in cui si intersecano immagini e impulsi. Qui non c’è solitudine né alienazione. Argento verde è una gazzarra estatica di gocce e scrosci fortuiti, in una sintassi fatta di continui scivolamenti.
I filmati di Pollock all’opera nel suo granaio non mostrano violenza né delirio nel processo creativo: si muoveva metodicamente a scatti, scagliando i suoi archi di colore con calma e compostezza. Lee Krasner si stupiva dinanzi alla misteriosa tecnica virtuosistica del marito che «lavorava in aria sapendo dove atterrerà». La definiva «del tutto straordinaria»: «Perfino i pittori indiani su sabbia lavoravano nella sabbia, non per aria». Pollock saltava e si piegava, con movenze quasi si danza, che coinvolgendo braccia, spalle e torso del pittore, e non – come nella tradizione – il polso e le dita, il suo punto debole sin da quando era studente. «Quello che mi interessa sono i ritmi della natura», dichiarò. Questi impulsi ipnotici, che diceva di invocare esplicitamente come uno sciamano tribale, lo portavano a una serenità contemplativa che può essere avvertita anche da chi osserva i suoi quadri migliori.
Il suo stato di trance, attingendo alla profondità dell’inconscio, richiamava la scrittura automatica del Surrealismo, una pratica letteraria che non si era mai affermata in pittura. Era come se l’anconsciato e odioso Pollock stesse scrivendo sotto dettatura di un Io superiore e più illuminato.
I visitatori a un’esposizione di Pollock del 1950 dissero che era come «camminare sotto una pioggia di meteoriti». Di fronte a un grande drip painting di Pollock non sappiamo dove guardare, non c’è nessuna storia, nessun punto focale. I dipinti sembrano vivi, come entità magiche e vibranti: un legame, forse, con gli imponenti totem del suo periodo picassiano. È come se stessimo guardando una realtà fisica a livello degli elementi, dove la materia si trasforma in energia ronzante. Può darsi che l’astrazione abbia liberato Pollock dal peso del personaggio. I suoi drip painting hanno un campo visivo panoramico. Sono un palpitante paesaggio primitivo, dove non sono nati esseri uomini, che tuttavia proiettano le prospettive infinite di un viaggio nel tempo a velocità fantascientifica, la nuova frontiera dell’era spaziale.
Roma, 16 dicembre 2018
Nessun commento
No comments yet.
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL
Sorry, the comment form is closed at this time.